Papers by Michele Maiolani
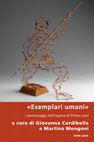
«Esemplari umani». I personaggi nell’opera di Primo Levi, a cura di Giovanna Cordibella e Martina Mengoni, Peter Lang, Berlino-Oxford, 2024
https://www.peterlang.com/document/1327945
Fin da 'Se questo è un uomo' e 'La tregua', Primo Lev... more https://www.peterlang.com/document/1327945
Fin da 'Se questo è un uomo' e 'La tregua', Primo Levi dispiega di fronte al lettore una costellazione di personaggi: personaggi «pescati» dal vivo, «riprodotti con un’impressione soggettiva»; personaggi «spaccati» e «ricombinati» (non solo da tipi umani esistenti ma anche dalla tradizione letteraria). Questo volume offre una prima mappatura critica dei personaggi leviani, e mira a dare avvio a indagini sulla loro costruzione, sulla loro configurazione narrativa e linguistica, così come sul loro statuto ontologico all’interno del mondo possibile dell’universo letterario. Studiare l’opera di Levi attraverso gli «esemplari umani» che la popolano si rivela un ingresso privilegiato: illumina da una nuova prospettiva i debiti verso la tradizione romanzesca del novecento (soprattutto tedesca e anglosassone), l’uso della prima persona e le strategie di proiezione dell’io, la dialettica tra scrittura testimoniale e racconto fantastico, la componente morale in rapporto all’uso di alcune tecniche narrative, prima tra tutte lo straniamento, e infine il rapporto, sempre controverso, tra presa diretta e «arrotondamento» finzionale.
"Primo Levi", a cura di Alberto Cavaglion, Carocci, 2023
Orientarsi nella vastissima bibliografia su Primo Levi è un’impresa ardua. Il volume indica una p... more Orientarsi nella vastissima bibliografia su Primo Levi è un’impresa ardua. Il volume indica una possibile sintesi, avvalendosi del contributo di studiosi già affermati che, insieme a giovani esordienti, offrono un primo bilancio su quanto è stato fatto e quanto ancora resta da fare per illuminare un prisma complesso. Accanto all’analisi di singole opere, sono stati enucleati i nodi problematici intorno ai quali persistono interpretazioni contrastanti: dal rapporto con l’ebraismo e lo Stato d’Israele alla funzione di Dante; dal ruolo del testimone – cioè la figura del superstite esaminata nell’arco di un mezzo secolo di scritture, da Se questo è un uomo a I sommersi e i salvati – fino all’uso delle fonti classiche, della Bibbia e dei miti.

Calvino A-Z, a cura di Marco Belpoliti, Electa, 2023
Il lemmario, a cura di Marco Belpoliti, riunisce 146 voci affidate a 56 autori e disegna una vera... more Il lemmario, a cura di Marco Belpoliti, riunisce 146 voci affidate a 56 autori e disegna una vera e propria mappa per entrare nel mondo-Calvino, nei suoi libri ma anche nei temi, nelle idee, nelle vicende della sua vita di scrittore e di intellettuale. Le singole voci sono testi e brevi saggi, non disposte in un ordine alfabetico, bensì radunate in gruppi tematici, che forniscono un esteso ritratto nell’opera dello scrittore ligure: nessun lemma tuttavia è una monade, ma crea un reticolo di rimandi ed echi, specchio della complessità e della varietà dell’opera calviniana. Tale costellazione, restituita dalla mappa in apertura del volume, suggerisce un’inedita lettura critica di uno degli autori più noti e importanti della nostra letteratura, uno dei pochi che, come scrive il curatore, continua a distanza di tempo a essere uno scrittore del XXI, e quasi sicuramente anche del XXII secolo.

Enthymema, 2023
This article investigates Primo Levi's representations of the origin of life, particularly consid... more This article investigates Primo Levi's representations of the origin of life, particularly considering his essays and science-fiction short stories. After introducing the two main sources of inspiration that Levi refers to when writing narratives on this subject, classical and biblical mythologies and Darwinian evolutionary theory, the article offers a close reading of two short stories, "I sintetici" and "Disfilassi", that depict a moment of 'second genesis' set in the near future. This process is seen by Levi from an ecological perspective in relation to the environmental risks that human technology and overpopulation pose to our planet. Following the analysis of the writer's essays about recent chemical and biological theories on how life originated on Earth, the last paragraph focuses on the tangencies between Levi's investigation of the origin of life and his reflections on the source of literary creativity, summed up by the short story "Carbonio".
https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema/article/view/19976/19020

The Italianist, 2023
The present article investigates Primo Levi’s anthropological readings in Scientific American bet... more The present article investigates Primo Levi’s anthropological readings in Scientific American between the late 1960s and the early 1980s. The fundamental importance of these anthropological publications in Levi’s career has long been disregarded by scholars who have studied the influence of Scientific American on the author’s work predominantly with regard to scientific and technological articles. After reading Scientific American’s anthropological essays and book reviews, Levi’s interests soon came to include actual books on folklore and anthropological studies. The present article retraces the path of his readings and provides a series of examples from the short stories collected in Vizio di forma and Lilít, as well as from the essays of L’altrui mestiere. The results of this survey of Levi’s anthropological sources also provide new insights into his creative process and lead to a rethinking of the role of ethnography in his intellectual history.
Questo articolo si concentra sulle letture antropologiche di Primo Levi sulla rivista Scientific American tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta. La critica ha sottovalutato a lungo l'importanza fondamentale di queste pubblicazioni antropologiche nella carriera di Levi, concentrandosi prevalentemente sull'influenza degli articoli di scienza e tecnologia di Scientific American sull'opera dello scrittore. Dopo aver letto articoli e recensioni di argomento antropologico su Scientific American, l'interesse di Levi presto passò a comprendere anche libri di folklore e antropologia. Questo articolo ricostruisce il percorso di queste letture e presenta una serie di esempi tratti dai racconti delle raccolte Vizio di forma e Lilít, oltre che dai saggi dell'Altrui mestiere. I risultati di questo sondaggio delle fonti antropologiche di Levi fornisce inoltre nuove prospettive sul suo processo creativo e invita a un ripensamento del ruolo dell'etnografia nella sua storia intellettuale.

Griseldaonline, 2023
Il saggio si concentra sui racconti di etnografia fantastica inclusi nel secondo numero della riv... more Il saggio si concentra sui racconti di etnografia fantastica inclusi nel secondo numero della rivista «Il semplice», scritti da Gianni Celati, Ginevra Bompiani, Ugo Cornia, Jean Talon, Stefano Benni e Henri Michaux. Dopo aver tracciato una panoramica della presenza dell’etnografia e dell’etnografia fantastica nella rivista, ho analizzato da vicino i rapporti di entrambi i generi con la letteratura di viaggio. Sono poi passato a considerare il ruolo cruciale dei Viaggi di Gulliver, evidenziando l’uso di diverse tipologie di straniamento di possibile derivazione swiftiana nei racconti raccolti nella rivista. Nell’ultimo paragrafo, ho concluso confrontando lo Gli Hiviniziki di Michaux con gli altri racconti brevi della sezione, evidenziando le continuità nel rappresentare il rapporto tra popolazioni immaginarie e ambiente.
This essay focuses on the fantasy ethnographic short stories published in the second issue of the literary review «Il semplice» and written by Gianni Celati, Ginevra Bompiani, Ugo Cornia, Jean Talon, Stefano Benni and Henri Michaux. After a brief discussion of the role of ethnography and fantasy ethnography in the publication, I considered their relationship with travel writing. I then focused on the key role of Gulliver's Travels, pointing out the possible Swiftian origin of the different kinds of estrangement adopted in the short stories collected in the review. In the last section, I compared and contrasted Michaux's Gli Hiviniziki with the other short stories, and I stressed the similarities in the representation of the relationship between imaginary populations and the natural environment.
Italian Studies, 2023
The relevance of Calvino’s anthropological readings, often overlooked by scholars, is particularl... more The relevance of Calvino’s anthropological readings, often overlooked by scholars, is particularly evident in his autobiographical project 'Passaggi obbligati'. The structure of the book, consisting of a selection of crucial turning points in the author’s life, is modelled on the theories presented by Arnold Van Gennep in 'Les Rites de passage'. Considering ‘La poubelle agréée’ as a case study, I will highlight Calvino’s shaping of his autobiography according to Van Gennep’s ritual frame, which can be described as a hybrid form of autobiography and ethnography, and which I define as ‘self-ethnography’. The influence of Mary Douglas’ reflection on impurity and garbage in her book 'Purity and Danger' will then be considered as a further crucial theoretical reference for Calvino’s construction of his self-ethnographic narrative.

Prisma Celati. Testi Contesti Immagini Ricordi (Mimesis), a cura di Eloisa Morra e Giacomo Raccis, 2023
Dopo una breve ricostruzione del rapporto di Gianni Celati con la 'Favola della botte' e 'I viagg... more Dopo una breve ricostruzione del rapporto di Gianni Celati con la 'Favola della botte' e 'I viaggi di Gulliver', vengono presi in considerazione i temi che lo scrittore deriva da Swift nella sua riflessione teorica sul romanzo e nella produzione narrativa coeva e successiva. Viene quindi considerata la centralità dello straniamento nelle opere di Celati e l’utilizzo di questo strumento viene messo in relazione con la prospettiva “aliena” adottata da Swift nei 'Viaggi di Gulliver'. L’ultima parte del saggio considera innanzitutto la vicinanza di alcuni aspetti delle vicende biografiche di Celati e Swift, in particolare in relazione ai temi dell’esilio e della condizione melanconica. Infine, il legame tra esilio e straniamento viene indagato in 'Verso la foce' e 'Fata morgana' e considerato anche in rapporto al fatto che queste opere si presentano come riscritture di testi reali o fittizi.
Notes in Italian Studies, 2021
Primo Levi pursues an anthropological analysis of work in several of his novels and essays, stres... more Primo Levi pursues an anthropological analysis of work in several of his novels and essays, stressing its centrality for approaching a definition of humanity. In this note I will consider a range of Levi’s texts which feature representations of work, including La tregua (1963), La chiave a stella (1978) and the short story ‘Gli stregoni’, collected in Lilìt e altri racconti (1981). I will also consider Levi’s original anthropological conception of the human as a ‘maker of receptacles’ as expressed in his essay ‘Una bottiglia di sole’ (1985), showing how this idea is embodied by several characters of the texts analysed here.

Diacritica, 2021
After conducting a brief preliminary investigation on the history (and ‘prehistory’) of Italo Cal... more After conducting a brief preliminary investigation on the history (and ‘prehistory’) of Italo Calvino’s Palomar, the present article investigates the possibility for the reader to represent the consciousness of the protagonist. The enquiry mainly focuses on the interaction between Palomar and the reader and is conducted through the lenses of David Herman’s and Alan Palmer’s cognitive theories of narratology. The aim is to determine how the reader can shape the protagonist’s consciousness by identifying and blending a series of actions and emotional events narrated by Calvino. The last part of the essay rediscusses the role of description in Palomar and proposes a new hypothesis on the crucial role of narration in the text by referring to Monika Fludernik’s conception of narrativity.
https://diacritica.it/letture-critiche/narrazione-e-rappresentazione-della-coscienza-del-signor-palomar.html
Leonardo Sciascia (1921-1989): Letteratura, critica, militanza civile, a c. di Marina Castiglione ed Elena Riccio, 2020
Il confronto tra le “narrazioni documentarie” sciasciane e i saggi di “microstoria” di Carlo Ginz... more Il confronto tra le “narrazioni documentarie” sciasciane e i saggi di “microstoria” di Carlo Ginzburg, spesso taciuto dalla critica, rivela diversi punti di contatto, non solo nei temi trattati, ma soprattutto nel campo delle scelte stilistiche e delle tecniche retorico-narrative adottate. Benché le opere dei due autori facciano riferimento a due distinti criteri di verità – quello della storiografia e quello della letteratura –, Sciascia e Ginzburg ricorrono a metodi e strumenti simili per far parlare documenti d’archivio lacunosi e di difficile lettura.
Diacritica, 2020
https://diacritica.it/letture-critiche/io-non-so-scrivere-queste-cose-come-le-sai-scrivere-tu-le-... more https://diacritica.it/letture-critiche/io-non-so-scrivere-queste-cose-come-le-sai-scrivere-tu-le-narrazioni-documentarie-di-andrea-camilleri-e-leonardo-sciascia.html
This paper considers two early works of Camilleri, La strage dimenticata (1984) and La bolla di componenda (1993) and compares and contrasts them with several of Sciascia’s documentary narratives – a hybrid non-fictional genre stemming from the rethinking of Manzoni’s Storia della Colonna infame. The two novelists adopt a set of shared formal and narrative features, which define this literary genre, and a similar epistemological perspective on historical sources. Nevertheless, especially in La bolla di componenda, Camilleri starts to detach from the norms of Sciascia’s documentary narrative and to give more space to fiction, which will be the distinctive aspect of his following historical novels.
In Natura Società Letteratura, Atti del XXII Congresso dell'ADI-Associazione degli Italianisti (B... more In Natura Società Letteratura, Atti del XXII Congresso dell'ADI-Associazione degli Italianisti (Bologna, 13-15 settembre 2018), a cura di A.Campana e F. Giunta, Roma, Adi editore, 2020
In "Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione audiovisiva", Atti del Convegno intern... more In "Ragusa e Montalbano: voci del territorio in traduzione audiovisiva", Atti del Convegno internazionale di studi (Ragusa, 19-20 ottobre 2017), a cura di Massimo Sturiale, Giuseppe Traina, Maurizio Zignale, Volume I, Fondazione Cesare e Doris Zipelli / Euno Edizioni, Leonforte 2019, pp. 217-234

«Scaffale Aperto. Rivista di Italianistica», 10, pp. 60-81, 2019
Il saggio esamina l’interesse di Calvino per aspetti epistemologici e metodologici della geografi... more Il saggio esamina l’interesse di Calvino per aspetti epistemologici e metodologici della geografia tra anni Sessanta e Ottanta. A partire dalle discussioni teoriche legate al progetto della rivista “Alì Babà”, viene poi indagato l’apporto della disciplina alla costruzione di un metodo d’indagine della realtà e allo sviluppo di una peculiare “narrazione geografica” calviniana, che coinvolge testi narrativi, saggistici e autobiografici.
This essay considers Calvino’s interest in epistemological and methodological aspects of geography between the sixties and the eighties. Starting from the theoretical debate which accompanied the project of the review “Alì Babà”, the article discusses the contribution of the discipline to the construction of a method to investigate reality and to the development of a “geographical narrative” in Calvino’s fictional, essayistic and autobiographical writings.
Una vita agra. Luciano Bianciardi da "Il lavoro culturale" ad "Aprire il fuoco", a cura di Arnaldo Bruni e Elisabetta Francioni
Todomodo, 2018
This article analyses the deep and enduring relationship between Leonardo Sciascia and Michel Fou... more This article analyses the deep and enduring relationship between Leonardo Sciascia and Michel Foucault, which has hitherto received little attention in Sciascia studies. The first part of this article uses the few clues in Sciascia's works to reconstruct which of the French philosopher's text he had read. The article then illustrates the thematic and methodological points of contact between the two, and concludes by comparing Sciascia's idea of Sicily with Foucault's concept of heterotopia.

Esperienze Letterarie, 2017
Molte volte i nomi di Henry Miller e di Luciano Bianciardi, suo traduttore, sono stati accostati ... more Molte volte i nomi di Henry Miller e di Luciano Bianciardi, suo traduttore, sono stati accostati dalla critica ; questa ha però spesso mancato di svolgere sondaggi approfonditi per chiarire il rapporto tra i due autori. La prima parte di questo saggio analizza in parallelo il percorso bianciardiano di traduzione dei due Tropici e quello creativo, che porterà alla stesura della Vita agra. Nei paragrafi successivi vengono presentati numerosi passi ed episodi che Luciano Bianciardi ha ripreso dai romanzi
di Miller e viene proposta una valutazione complessiva del ruolo dello scrittore americano nella produzione bianciardiana a livello narrativo ed epistemologico.
Many times the names of Henry Miller and Luciano Bianciardi, his translator in italian, have been linked, but still critical essays about them lack of depth. The first part of this paper analyzes at the same time the translation of the two Tropics and the steps which led to the writing of La vita agra. In the following paragraphs it will be shown that La vita agra includes many episodes taken up from Miller’s works. In conclusion an overall and precise evaluation of Miller’s role in Bianciardi’s narrative and thought will be briefly presented.
De nombreuses fois, les noms de Henry Miller et de Luciano Bianciardi, son traducteur, ont été réunis par la critique qui a cependant souvent oublié d’effectuer une recherche approfondie pour élucider le rapport entre les deux auteurs. La première partie de cet essai analyse en parallèle le chemin bianciardien de traduction des deux Tropici et celui créatif, qui conduira à la rédaction de La vita agra. Dans les paragraphes suivants sont présentés de nombreux passages et épisodes que Luciano Bianciardi a repris des romans de Miller et est une proposée évaluation globale du rôle de l’écrivain américain dans la production de Bianciardi au niveau narratif et épistémologique.
Muchas veces los nombres de Henry Miller y de Luciano Bianciardi, su traductor, han sido asociados por la crítica ; sin embargo dicha crítica, a menudo, no ha desarrollado estudios exhaustivos para aclarar la relación entre ambos autores. La primera parte de este ensayo analiza de manera paralela el recorrido bianciardiano de la traducción de los dos Tropici y el creativo, que llevará a la redacción de La vita agra. En los apartados sucesivos se presentan numerosos pasos y episodios que
Luciano Bianciardi retomó de las novelas de Miller y se propone una evaluación global del rol del escritor norteamericano en la producción bianciardiana a nivel narrativo y epistemológico.
Die Namen von Henry Miller und Luciano Bianciardi, seinem italienischen Übersetzer, wurden von Kritikern oftmals im gleichen Atemzug genannt, aber gerade dies hat eingehendere Untersuchungen zur Klärung des Verhältnisses zwischen den beiden Autoren oft behindert. Der erste Teildes Aufsatzes analysiert parallel den Verlauf von Bianciardis Übersetzungsarbeit an den beiden Tropici sowie den kreativen Prozess, der zum Werk Vita agra führen wird. In den folgenden Abschnitten werden zahlreiche Passagen und Episoden vorgestellt, die Luciano Bianciardi aus Millers Romanen übernommen hat, um darauf hin eine Gesamtbewertung der Rolle des amerikanischen Schriftstellers auf narrativer und epistemologischer Ebene in der schriftstellerischen Produktion Bianciardis vorzunehmen.

Il problema principale che verrà preso in esame in questo lavoro è la relazione tra autore, narra... more Il problema principale che verrà preso in esame in questo lavoro è la relazione tra autore, narratore e protagonista nella Vita agra di Luciano Bianciardi e, di conseguenza, del genere a cui il testo appartiene. Dopo aver chiarito questi punti preliminari (spesso fraintesi dalla critica), verranno affrontate le questioni relative alla natura ibrida della scrittura bianciardiana e al meccanismo allegorico di cui l’autore si serve nel romanzo. Nel corso della trattazione saranno necessari alcuni riferimenti alle altre parti della trilogia bianciardiana, Il lavoro culturale e L’integrazione, anche per mostrare l’evoluzione delle soluzioni adottate dall’autore in prospettiva diacronica e spiegarne così l’appropriatezza e l’efficacia nelle varie situazioni narrative. In conclusione viene proposto un accostamento ad altri autori che negli stessi anni utilizzano tecniche narrative e impostazioni simili a quelle di Bianciardi (Ottieri, Parise, Volponi).
The main focus of this paper is the relationship among author, narrator and main character in Luciano Bianciardi’s La vita agra. After the analysis of this preliminary matter (often misunderstood by critics), this essay will deal with the main issues of Bianciard’s work: the hybrid writing and the allegorical mechanism. The following paragraphs will refer shortly to the other chapters of Bianciardi’s trilogy, Il lavoro culturale and L’integrazione, in order to show the diachronic development
and the efficacy of the author’s choices. The last paragraph of this paper connects Bianciardi’s work to novels of other italian writers working in the same years and adopting similar narrative techniques (Ottieri, Parise, Volponi).




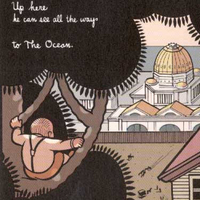




Uploads
Papers by Michele Maiolani
Fin da 'Se questo è un uomo' e 'La tregua', Primo Levi dispiega di fronte al lettore una costellazione di personaggi: personaggi «pescati» dal vivo, «riprodotti con un’impressione soggettiva»; personaggi «spaccati» e «ricombinati» (non solo da tipi umani esistenti ma anche dalla tradizione letteraria). Questo volume offre una prima mappatura critica dei personaggi leviani, e mira a dare avvio a indagini sulla loro costruzione, sulla loro configurazione narrativa e linguistica, così come sul loro statuto ontologico all’interno del mondo possibile dell’universo letterario. Studiare l’opera di Levi attraverso gli «esemplari umani» che la popolano si rivela un ingresso privilegiato: illumina da una nuova prospettiva i debiti verso la tradizione romanzesca del novecento (soprattutto tedesca e anglosassone), l’uso della prima persona e le strategie di proiezione dell’io, la dialettica tra scrittura testimoniale e racconto fantastico, la componente morale in rapporto all’uso di alcune tecniche narrative, prima tra tutte lo straniamento, e infine il rapporto, sempre controverso, tra presa diretta e «arrotondamento» finzionale.
https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema/article/view/19976/19020
Questo articolo si concentra sulle letture antropologiche di Primo Levi sulla rivista Scientific American tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta. La critica ha sottovalutato a lungo l'importanza fondamentale di queste pubblicazioni antropologiche nella carriera di Levi, concentrandosi prevalentemente sull'influenza degli articoli di scienza e tecnologia di Scientific American sull'opera dello scrittore. Dopo aver letto articoli e recensioni di argomento antropologico su Scientific American, l'interesse di Levi presto passò a comprendere anche libri di folklore e antropologia. Questo articolo ricostruisce il percorso di queste letture e presenta una serie di esempi tratti dai racconti delle raccolte Vizio di forma e Lilít, oltre che dai saggi dell'Altrui mestiere. I risultati di questo sondaggio delle fonti antropologiche di Levi fornisce inoltre nuove prospettive sul suo processo creativo e invita a un ripensamento del ruolo dell'etnografia nella sua storia intellettuale.
This essay focuses on the fantasy ethnographic short stories published in the second issue of the literary review «Il semplice» and written by Gianni Celati, Ginevra Bompiani, Ugo Cornia, Jean Talon, Stefano Benni and Henri Michaux. After a brief discussion of the role of ethnography and fantasy ethnography in the publication, I considered their relationship with travel writing. I then focused on the key role of Gulliver's Travels, pointing out the possible Swiftian origin of the different kinds of estrangement adopted in the short stories collected in the review. In the last section, I compared and contrasted Michaux's Gli Hiviniziki with the other short stories, and I stressed the similarities in the representation of the relationship between imaginary populations and the natural environment.
https://diacritica.it/letture-critiche/narrazione-e-rappresentazione-della-coscienza-del-signor-palomar.html
This paper considers two early works of Camilleri, La strage dimenticata (1984) and La bolla di componenda (1993) and compares and contrasts them with several of Sciascia’s documentary narratives – a hybrid non-fictional genre stemming from the rethinking of Manzoni’s Storia della Colonna infame. The two novelists adopt a set of shared formal and narrative features, which define this literary genre, and a similar epistemological perspective on historical sources. Nevertheless, especially in La bolla di componenda, Camilleri starts to detach from the norms of Sciascia’s documentary narrative and to give more space to fiction, which will be the distinctive aspect of his following historical novels.
This essay considers Calvino’s interest in epistemological and methodological aspects of geography between the sixties and the eighties. Starting from the theoretical debate which accompanied the project of the review “Alì Babà”, the article discusses the contribution of the discipline to the construction of a method to investigate reality and to the development of a “geographical narrative” in Calvino’s fictional, essayistic and autobiographical writings.
di Miller e viene proposta una valutazione complessiva del ruolo dello scrittore americano nella produzione bianciardiana a livello narrativo ed epistemologico.
Many times the names of Henry Miller and Luciano Bianciardi, his translator in italian, have been linked, but still critical essays about them lack of depth. The first part of this paper analyzes at the same time the translation of the two Tropics and the steps which led to the writing of La vita agra. In the following paragraphs it will be shown that La vita agra includes many episodes taken up from Miller’s works. In conclusion an overall and precise evaluation of Miller’s role in Bianciardi’s narrative and thought will be briefly presented.
De nombreuses fois, les noms de Henry Miller et de Luciano Bianciardi, son traducteur, ont été réunis par la critique qui a cependant souvent oublié d’effectuer une recherche approfondie pour élucider le rapport entre les deux auteurs. La première partie de cet essai analyse en parallèle le chemin bianciardien de traduction des deux Tropici et celui créatif, qui conduira à la rédaction de La vita agra. Dans les paragraphes suivants sont présentés de nombreux passages et épisodes que Luciano Bianciardi a repris des romans de Miller et est une proposée évaluation globale du rôle de l’écrivain américain dans la production de Bianciardi au niveau narratif et épistémologique.
Muchas veces los nombres de Henry Miller y de Luciano Bianciardi, su traductor, han sido asociados por la crítica ; sin embargo dicha crítica, a menudo, no ha desarrollado estudios exhaustivos para aclarar la relación entre ambos autores. La primera parte de este ensayo analiza de manera paralela el recorrido bianciardiano de la traducción de los dos Tropici y el creativo, que llevará a la redacción de La vita agra. En los apartados sucesivos se presentan numerosos pasos y episodios que
Luciano Bianciardi retomó de las novelas de Miller y se propone una evaluación global del rol del escritor norteamericano en la producción bianciardiana a nivel narrativo y epistemológico.
Die Namen von Henry Miller und Luciano Bianciardi, seinem italienischen Übersetzer, wurden von Kritikern oftmals im gleichen Atemzug genannt, aber gerade dies hat eingehendere Untersuchungen zur Klärung des Verhältnisses zwischen den beiden Autoren oft behindert. Der erste Teildes Aufsatzes analysiert parallel den Verlauf von Bianciardis Übersetzungsarbeit an den beiden Tropici sowie den kreativen Prozess, der zum Werk Vita agra führen wird. In den folgenden Abschnitten werden zahlreiche Passagen und Episoden vorgestellt, die Luciano Bianciardi aus Millers Romanen übernommen hat, um darauf hin eine Gesamtbewertung der Rolle des amerikanischen Schriftstellers auf narrativer und epistemologischer Ebene in der schriftstellerischen Produktion Bianciardis vorzunehmen.
The main focus of this paper is the relationship among author, narrator and main character in Luciano Bianciardi’s La vita agra. After the analysis of this preliminary matter (often misunderstood by critics), this essay will deal with the main issues of Bianciard’s work: the hybrid writing and the allegorical mechanism. The following paragraphs will refer shortly to the other chapters of Bianciardi’s trilogy, Il lavoro culturale and L’integrazione, in order to show the diachronic development
and the efficacy of the author’s choices. The last paragraph of this paper connects Bianciardi’s work to novels of other italian writers working in the same years and adopting similar narrative techniques (Ottieri, Parise, Volponi).
Fin da 'Se questo è un uomo' e 'La tregua', Primo Levi dispiega di fronte al lettore una costellazione di personaggi: personaggi «pescati» dal vivo, «riprodotti con un’impressione soggettiva»; personaggi «spaccati» e «ricombinati» (non solo da tipi umani esistenti ma anche dalla tradizione letteraria). Questo volume offre una prima mappatura critica dei personaggi leviani, e mira a dare avvio a indagini sulla loro costruzione, sulla loro configurazione narrativa e linguistica, così come sul loro statuto ontologico all’interno del mondo possibile dell’universo letterario. Studiare l’opera di Levi attraverso gli «esemplari umani» che la popolano si rivela un ingresso privilegiato: illumina da una nuova prospettiva i debiti verso la tradizione romanzesca del novecento (soprattutto tedesca e anglosassone), l’uso della prima persona e le strategie di proiezione dell’io, la dialettica tra scrittura testimoniale e racconto fantastico, la componente morale in rapporto all’uso di alcune tecniche narrative, prima tra tutte lo straniamento, e infine il rapporto, sempre controverso, tra presa diretta e «arrotondamento» finzionale.
https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema/article/view/19976/19020
Questo articolo si concentra sulle letture antropologiche di Primo Levi sulla rivista Scientific American tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta. La critica ha sottovalutato a lungo l'importanza fondamentale di queste pubblicazioni antropologiche nella carriera di Levi, concentrandosi prevalentemente sull'influenza degli articoli di scienza e tecnologia di Scientific American sull'opera dello scrittore. Dopo aver letto articoli e recensioni di argomento antropologico su Scientific American, l'interesse di Levi presto passò a comprendere anche libri di folklore e antropologia. Questo articolo ricostruisce il percorso di queste letture e presenta una serie di esempi tratti dai racconti delle raccolte Vizio di forma e Lilít, oltre che dai saggi dell'Altrui mestiere. I risultati di questo sondaggio delle fonti antropologiche di Levi fornisce inoltre nuove prospettive sul suo processo creativo e invita a un ripensamento del ruolo dell'etnografia nella sua storia intellettuale.
This essay focuses on the fantasy ethnographic short stories published in the second issue of the literary review «Il semplice» and written by Gianni Celati, Ginevra Bompiani, Ugo Cornia, Jean Talon, Stefano Benni and Henri Michaux. After a brief discussion of the role of ethnography and fantasy ethnography in the publication, I considered their relationship with travel writing. I then focused on the key role of Gulliver's Travels, pointing out the possible Swiftian origin of the different kinds of estrangement adopted in the short stories collected in the review. In the last section, I compared and contrasted Michaux's Gli Hiviniziki with the other short stories, and I stressed the similarities in the representation of the relationship between imaginary populations and the natural environment.
https://diacritica.it/letture-critiche/narrazione-e-rappresentazione-della-coscienza-del-signor-palomar.html
This paper considers two early works of Camilleri, La strage dimenticata (1984) and La bolla di componenda (1993) and compares and contrasts them with several of Sciascia’s documentary narratives – a hybrid non-fictional genre stemming from the rethinking of Manzoni’s Storia della Colonna infame. The two novelists adopt a set of shared formal and narrative features, which define this literary genre, and a similar epistemological perspective on historical sources. Nevertheless, especially in La bolla di componenda, Camilleri starts to detach from the norms of Sciascia’s documentary narrative and to give more space to fiction, which will be the distinctive aspect of his following historical novels.
This essay considers Calvino’s interest in epistemological and methodological aspects of geography between the sixties and the eighties. Starting from the theoretical debate which accompanied the project of the review “Alì Babà”, the article discusses the contribution of the discipline to the construction of a method to investigate reality and to the development of a “geographical narrative” in Calvino’s fictional, essayistic and autobiographical writings.
di Miller e viene proposta una valutazione complessiva del ruolo dello scrittore americano nella produzione bianciardiana a livello narrativo ed epistemologico.
Many times the names of Henry Miller and Luciano Bianciardi, his translator in italian, have been linked, but still critical essays about them lack of depth. The first part of this paper analyzes at the same time the translation of the two Tropics and the steps which led to the writing of La vita agra. In the following paragraphs it will be shown that La vita agra includes many episodes taken up from Miller’s works. In conclusion an overall and precise evaluation of Miller’s role in Bianciardi’s narrative and thought will be briefly presented.
De nombreuses fois, les noms de Henry Miller et de Luciano Bianciardi, son traducteur, ont été réunis par la critique qui a cependant souvent oublié d’effectuer une recherche approfondie pour élucider le rapport entre les deux auteurs. La première partie de cet essai analyse en parallèle le chemin bianciardien de traduction des deux Tropici et celui créatif, qui conduira à la rédaction de La vita agra. Dans les paragraphes suivants sont présentés de nombreux passages et épisodes que Luciano Bianciardi a repris des romans de Miller et est une proposée évaluation globale du rôle de l’écrivain américain dans la production de Bianciardi au niveau narratif et épistémologique.
Muchas veces los nombres de Henry Miller y de Luciano Bianciardi, su traductor, han sido asociados por la crítica ; sin embargo dicha crítica, a menudo, no ha desarrollado estudios exhaustivos para aclarar la relación entre ambos autores. La primera parte de este ensayo analiza de manera paralela el recorrido bianciardiano de la traducción de los dos Tropici y el creativo, que llevará a la redacción de La vita agra. En los apartados sucesivos se presentan numerosos pasos y episodios que
Luciano Bianciardi retomó de las novelas de Miller y se propone una evaluación global del rol del escritor norteamericano en la producción bianciardiana a nivel narrativo y epistemológico.
Die Namen von Henry Miller und Luciano Bianciardi, seinem italienischen Übersetzer, wurden von Kritikern oftmals im gleichen Atemzug genannt, aber gerade dies hat eingehendere Untersuchungen zur Klärung des Verhältnisses zwischen den beiden Autoren oft behindert. Der erste Teildes Aufsatzes analysiert parallel den Verlauf von Bianciardis Übersetzungsarbeit an den beiden Tropici sowie den kreativen Prozess, der zum Werk Vita agra führen wird. In den folgenden Abschnitten werden zahlreiche Passagen und Episoden vorgestellt, die Luciano Bianciardi aus Millers Romanen übernommen hat, um darauf hin eine Gesamtbewertung der Rolle des amerikanischen Schriftstellers auf narrativer und epistemologischer Ebene in der schriftstellerischen Produktion Bianciardis vorzunehmen.
The main focus of this paper is the relationship among author, narrator and main character in Luciano Bianciardi’s La vita agra. After the analysis of this preliminary matter (often misunderstood by critics), this essay will deal with the main issues of Bianciard’s work: the hybrid writing and the allegorical mechanism. The following paragraphs will refer shortly to the other chapters of Bianciardi’s trilogy, Il lavoro culturale and L’integrazione, in order to show the diachronic development
and the efficacy of the author’s choices. The last paragraph of this paper connects Bianciardi’s work to novels of other italian writers working in the same years and adopting similar narrative techniques (Ottieri, Parise, Volponi).
Please see the event programme below. The conference languages will be English and Italian. Anyone willing to attend, please register by sending an e-mail to [email protected].
A cura di Cecilia Monina, Gabriele Gimmelli, Michele Maiolani, Michele Ronchi Stefanati
7, 14, 21, 28 maggio 2021
Iscrizione online (ZOOM): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmtPROKQ843qHqLjWSjMz1nGUYxIfi99NUmxO3AlX4W9pdQg/viewform
Diretta youtube: www.tinyurl.com/levi2021
Informazioni e volantini delle giornate: https://www.italiano.unibe.ch/ricerca/letteratura_italiana/convegni_workshop_conferenze/esemplari_umani_i_personaggi_nellopera_di_primo_levi/index_ita.html
In quei giorni e in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento alto spirava sulla faccia della terra: il mondo intorno a noi sembrava ritornato al Caos primigenio, e brulicava di esemplari umani scaleni, difettivi, abnormi; e ciascuno di essi si agitava, in moti ciechi o deliberati, in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi. (Primo Levi, La tregua, 1963)
Far morire un personaggio è criminale; senza esagerare, non è come uccidere una persona, ma come esperienza in parte coincide. Tracce di questa mia ossessione per i personaggi si trovano in Vizio di forma[…] È difficile definirli in modo filosofico; certamente non sono dei mammiferi, perché si riproducono a modo loro: si ha libertà completa su di loro; tu, autore, ti senti dotato di poteri senza limiti, puoi fare di un personaggio quello ti pare, puoi ammazzarlo, puoi renderlo bellissimo, onnipotente, perverso, puoi farlo soffrire, godere, e questa è stata per me un’esperienza abbastanza nuova, un senso di onnipotenza infantile; è vero, il bambino si costruisce un universo dove può fare quello che vuole, e sotto quest’aspetto scrivere un romanzo è una regressione. (Primo Levi, intervista per «Il Globo», 13 giugno 1982)
Il convegno internazionale "Esemplari umani". I personaggi nell'opera di Primo Levi vuole sollecitare una riflessione critica sui personaggi che popolano l’opera di Primo Levi, sulla loro costruzione, sulla loro configurazione narrativa e linguistica, sul loro statuto ontologico all’interno del mondo possibile dell’universo letterario, sulla relazione e sull’eventuale scarto tra dimensione finzionale e vicenda storica; e ancora, sulla ricorrenza di alcuni personaggi chiave in opere e generi differenti, sui prestiti da altri autori e da altri personaggi, sul dialogo che intrattengono con il lettore. Ciascun intervento proporrà l’analisi e la lettura critica di un personaggio, antropomorfo o zoomorfo, senza distinzione di genere (prosa, poesia, narrativa, saggistica, memorialistica, fantascienza). L'indagine potrà abbracciare uno o più testi dell’opera di Levi, e potrà avere carattere sia sincronico che diacronico, potrà prendere in esame le relazioni con altri personaggi, principali o secondari, eventuali rapporti duali e appartenenze a gruppi.
Programma
Venerdì 7 maggio 2021, ore 16:00
Dal vero e dal vivo. Persone, figure, ritratti
Ore 16.00: Saluti e introduzione al convegno e alla giornata
Ore 16.20: Domenico Scarpa (Centro Internazionale di Studi Primo Levi),«Me, mi conoscete». La postura di Capaneo e «gli occhi dell’uomo Kraus»
Ore 16.40: Matteo Giancotti (Università di Padova), L’infanzia è morta ad Auschwitz. Ricomposizione del dittico Emilia-Hurbinek
Ore 17.00: Discussione
Ore 17.20: Pausa
Ore 17.35: Roberta Mori (Centro Internazionale di Studi Primo Levi,«Perfino con una punta di spavalderia». Sandro / Sandro Delmastro: storia di un «ambigeno».
Ore 17.55: Giovanna Cordibella (Università di Berna), Il laboratorio della Buna negli specchi della scrittura. Il personaggio di Gerhard Goldbaum
Ore 18.15: Discussione
Venerdì 14 maggio, ore 16:00
L’avventura della finzione. Eroi, nomadi, imposture
Ore 16.00: Saluti e introduzione alla giornata
Ore 16.10: Giovanni Miglianti (Università di Yale),«Eh no: tutto non le posso dire»: l'armatura di Faussone e le pellicole di Levi
Ore 16.30: Angela Siciliano (Università di Pisa), Gedale «esiste nella realtà»: ritratto di un partigiano tra storia e letteratura
Ore 16.50: Discussione
Ore 17.20: Pausa
Ore 17.30: Martina Mengoni (Università di Berna), Funzione Mann versus funzione Conrad nei personaggi di Primo Levi
Ore 17.50: Discussione
Venerdì 21 maggio, ore 16:00
Prime persone. Un altro modo di dire io
Ore 16.00: Saluti e introduzione alla giornata
Ore 16.10: Riccardo Capoferro (Sapienza Università di Roma), L'autore, il testimone e il vecchio marinaio: echi di Coleridge nel personaggio-Levi
Ore 16.30: Anna Baldini (Università per Stranieri di Siena), L’Autore e i Personaggi. Antonio Casella, scrittore ambigeno e falsario
Ore 16.50: Discussione
Ore 17.20: Pausa
Ore 17:30 Robert S. C. Gordon (Università di Cambridge), I nomi vuoti e il sistema dei personaggi in Primo Levi. James Collins
Ore 17:50 Discussione
Venerdì 28 maggio, ore 16:00
Fatti strani. Umani, animali, oggetti
Ore 16.00: Saluti e introduzione alla giornata
Ore 16.10: Damiano Benvegnù (Università di Dartmouth), Innaminka il canguro: funzione etico-epistemologica dei personaggi animali in Primo Levi
Ore 16.30: Michele Maiolani (Università di Cambridge), Wilkins, etnologo stregone
Ore 16.50: Discussione
Ore 17.20: Pausa
Ore 17.30: Keynote speech, Marco Belpoliti (Università di Bergamo), Knall
Ore 18.10 Discussione finale
Erica Bellia (Cambridge)
Michele Maiolani (Cambridge)
KEYNOTE SPEAKERS
Luca Somigli (Toronto) – 19/03/2021
Federica G Pedriali (Edinburgh) – 20/03/2021
RESPONDENTS
Valeria Taddei (Oxford)– 19/03/2021
Karen Pinkus (Cornell) – 20/03/2021
SPEAKERS
Massimiliano Tortora (Turin) – 19/03/2021
Tiziano Toracca (Ghent-Turin) – 19/03/2021
Florian Mussgnug (UCL) – 19/03/2021
Gloria Scarfone (Pisa) – 20/03/2021
Alessandra Diazzi (Manchester) – 20/03/2021
Carlo Tirinanzi de Medici (Trento) – 20/03/2021
The critical category of Modernism has been applied to Italian studies only since the 1990s. It has allowed scholars to set Italian literature of the early twentieth century into a broader European context. In particular, the use of distorted and non-realistic literary time and space, the major influence of psychoanalysis on literature, a tendency to fragmentation in narrative structures and characters, and linguistic experimentalism have all been identified as common traits shared by European and Italian Modernist novels. And the novel itself has been confirmed as the literary form par excellence where the Modernist ‘revolution’ took place.
The use of the notion of Modernism, borrowed from the Anglo-American critical tradition, in Italian Studies has not been limited to the most recognisably Modernist authors of the early twentieth century (key names are those of Luigi Pirandello, Italo Svevo, Carlo Emilio Gadda) but has also been extended backwards, to consider authors and works of the nineteenth century traditionally defined as ‘decadenti’.
However, there has still been some hesitation in applying the category of Modernism to the literature produced after 1945. After the Second World War and as a reaction to Neorealism, in the late 1950s many authors started to resort to narrative strategies and techniques which can again be assimilated to Modernism. If this trend has been associated with the global phenomenon of Postmodernism, some scholars have recently challenged this well-established connection, proposing instead the category of Neomodernism, which stresses the elements of continuity with the Modernist moment. A wide range of novels written and published in Italy between the late 1950s and the mid-1970s by authors such as Elsa Morante, Paolo Volponi and Pier Paolo Pasolini, is deeply rooted in the traditions of Modernism and share ideological as well as stylistic similarities. This critical distinction between Postmodernism and Neomodernism, far from being the mere replacement of a label with another, has deep ideological implications and a heuristic power that demands further investigation.
EVENT OVERVIEW
While Primo Levi is mainly known for his painstaking and harsh books about his imprisonment in Auschwitz, he also wrote two collections of short stories that can be labelled as science fiction: 'Storie naturali' (1966) and 'Vizio di forma' (1971). A chemist by training, Levi wrote these stories at a time when science fiction was still perceived as unworthy of attention by Italian intellectuals—to the extent that 'Storie naturali' was initially published under a pseudonym. In both books, Levi uses science fiction to investigate the ethical implications of technological progress and probe its hidden and inherent flaws while adopting a tone that was only apparently light. The eerie effect reached by many of these short stories is due to a strong clash: the literary genre was considered superficial and disengaged by the vast majority of Levi’s contemporaries, and yet the writer addresses crucial existential questions in his narrations of clones, intelligent technologies, mutant animals.
By drawing attention to Levi’s contributions in science fiction, this one-day conference aims to contribute to reshaping the scholarly reputation of this genre within Italian Studies and to question Levi’s perception vis-à-vis his position within the hierarchy of genres. This event brings together some of the most renowned scholars who have explored the intersections between his work and science fiction. The speakers will dialogue with early-career researchers and established Levi scholars to foster the debate on this new area of research and explore it from an interdisciplinary perspective.